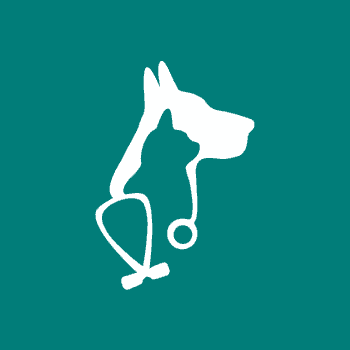La cataratta del cane ha origine principalmente da predisposizione genetica ereditaria presente in oltre 100 razze con pattern di trasmissione autosomica recessiva o dominante. Diabete mellito causa cataratta nell’80% dei cani diabetici per accumulo di sorbitolo nel cristallino che determina rigonfiamento osmotico e denaturazione proteica. Invecchiamento, traumi oculari, infiammazioni croniche intraoculari e farmaci come corticosteroidi sistemici rappresentano cause acquisite. Fattori nutrizionali come carenze vitaminiche o aminoacidiche possono contribuire, particolarmente nei cuccioli. L’opacizzazione risulta dall’alterazione delle proteine cristalline specializzate che perdono trasparenza.
I sintomi principali includono opacità biancastra-bluastra visibile nella pupilla, difficoltà visive inizialmente notturne con esitazione durante passeggiate al buio, comportamenti di ricerca tattile aumentata e collisioni occasionali con oggetti. Il cane mostra riluttanza a scendere scale, maggiore dipendenza dalle vocalizzazioni del proprietario, perdita di coordinazione durante il gioco. Con la progressione si sviluppano deficit visivi diurni, disorientamento, ansia correlata alla perdita visiva e attaccamento eccessivo. Nelle forme rapidamente progressive come quella diabetica si osserva perdita improvvisa di localizzazione di cibo-acqua.
Il trattamento definitivo è chirurgico tramite facoemulsificazione con impianto di lenti intraoculari artificiali, non esistendo farmaci efficaci per invertire l’opacizzazione. L’intervento ha successo nel 90-95% dei casi ripristinando visione funzionale duratura. Richiede anestesia generale, valutazione pre-operatoria della funzionalità retinica tramite elettroretinografia e stabilizzazione di condizioni sistemiche come diabete. Post-operatorio necessita terapie topiche intensive con antibiotici-antinfiammatori per 4-6 settimane, restrizioni attività e controlli ravvicinati. Senza trattamento progredisce verso cecità completa ma i cani si adattano bene.
La prevenzione si basa su controllo ottimale del diabete mellito per prevenire cataratta diabetica, protezione da traumi oculari, screening genetico nelle razze predisposte per allevamento responsabile. Controlli oftalmologici regolari in razze a rischio consentono diagnosi precoce. Alimentazione ricca di antiossidanti (vitamina E, C, selenio), carotenoidi e omega-3 protegge dal danno ossidativo cristallinoideo. Test genetici identificano portatori permettendo selezione riproduttiva. Evitare farmaci che possono indurre cataratta, mantenere salute oculare generale attraverso nutrizione bilanciata. Identificazione precoce ottimizza possibilità terapeutiche e previene complicanze.
Preoccupazioni? Dubbi?
Richiedi una visita veterinaria o un secondo consulto
❤️ La salute del tuo pet è un lavoro di squadra: tu, noi e il tuo veterinario. Richiedi un secondo consulto o una visita veterinaria a domicilio.
La cataratta è l’opacizzazione del cristallino, la lente trasparente dell’occhio che focalizza la luce sulla retina. Rappresenta una delle principali cause di cecità nel cane, colpendo il 5-10% della popolazione canina. Può essere congenita, ereditaria, diabetica o senile. La perdita di trasparenza impedisce alla luce di raggiungere la retina, causando compromissione visiva progressiva che può portare alla cecità completa senza trattamento.
I primi segni includono opacità biancastra o bluastra visibile nella pupilla, difficoltà visive notturne, esitazione durante passeggiate al buio e comportamenti di ricerca tattile aumentata. Il cane può mostrare riluttanza a scendere scale, collisioni occasionali con oggetti e maggiore dipendenza dalle vocalizzazioni del proprietario. L’opacità è inizialmente parziale e progressivamente coinvolge tutto il cristallino.
Le cause principali includono predisposizione genetica ereditaria, diabete mellito, invecchiamento, traumi oculari e infiammazioni croniche. Oltre 100 razze canine presentano forme ereditarie, mentre l’80% dei cani diabetici sviluppa cataratta entro 12 mesi. L’accumulo di sorbitolo nel cristallino nei diabetici causa rigonfiamento e denaturazione delle proteine cristalline, portando a rapida opacizzazione.
La diagnosi richiede esame oftalmologico specialistico con biomicroscopia (lampada a fessura) per valutare localizzazione e grado di opacizzazione. L’elettroretinografia verifica la funzionalità retinica prima dell’intervento chirurgico. Esami del sangue identificano diabete o altre patologie sistemiche. L’oftalmoscopia e l’ecografia oculare valutano le strutture posteriori dell’occhio quando la cataratta è densa.
Razze ad alto rischio includono Cocker Spaniel Americano, Golden Retriever, Labrador Retriever, Pastore Tedesco e Boston Terrier. Il Cocker Spaniel presenta incidenza elevata con cataratta giovanile a trasmissione autosomica recessiva. Razze toy come Barboncino e Yorkshire Terrier mostrano predisposizione per forme congenite. La predisposizione è genetica con pattern di trasmissione razza-specifici.
Il trattamento definitivo è chirurgico tramite facoemulsificazione con impianto di lenti intraoculari artificiali. Non esistono farmaci efficaci per invertire l’opacizzazione. L’intervento ha successo nel 90-95% dei casi, ripristinando visione funzionale. La chirurgia richiede anestesia generale e valutazione pre-operatoria della funzionalità retinica. Terapie post-operatorie intensive sono essenziali per 4-6 settimane.
La prognosi è eccellente con trattamento chirurgico: oltre il 90% dei cani recupera visione funzionale duratura. Senza trattamento, la cataratta progredisce verso cecità completa, ma i cani si adattano bene usando olfatto e udito. Complicanze come uveite o glaucoma possono svilupparsi in cataratte mature. Il successo chirurgico dipende dalla tempestività dell’intervento e dall’assenza di patologie retiniche concomitanti.
La cataratta non influenza direttamente la longevità: i cani vivono normalmente anche con cecità completa. Le aspettative di vita dipendono dalle condizioni sottostanti come diabete mellito. Cani diabetici richiedono controllo glicemico ottimale per prevenire complicanze sistemiche. Con adattamenti ambientali appropriati, la qualità di vita rimane eccellente anche senza intervento chirurgico.
No, la cataratta in sé non causa dolore, ma complicanze come uveite secondaria o glaucoma possono essere dolorose. Segni di dolore oculare includono arrossamento, lacrimazione, chiusura palpebrale e riluttanza al contatto. L’intervento chirurgico può causare discomfort temporaneo gestibile con analgesici. Il dolore post-operatorio è generalmente lieve e si risolve entro pochi giorni con terapie appropriate.
La prevenzione include controllo ottimale del diabete mellito, protezione da traumi oculari, screening genetico nelle razze predisposte e alimentazione ricca di antiossidanti. Test genetici permettono identificazione di portatori per allevamento responsabile. Controlli oftalmologici regolari in razze a rischio consentono diagnosi precoce. Evitare farmaci che possono indurre cataratta e mantenere salute oculare generale attraverso nutrizione bilanciata.
LIBRETTO VETERINARIO
Con il libretto veterinario di DoctorVet è possibile registrare e aggiornare informazioni importanti sulla salute del proprio animale, soprattutto se è soggetto a patologie o malato.
Il libretto sanitario ti aiuta a gestire vaccinazioni e trattamenti periodici. Puoi caricare prescrizioni, diagnosi, farmaci, esami, referti e note cliniche.
Attiva i promemoria per una gestione più facile ed efficace.
*Il veterinario può aggiornare il libretto veterinario con nuove informazioni, prescrizioni, terapie, analisi, esami e referti, consentendo una migliore gestione della salute dell’animale.
Che cos’è la cataratta nel cane
La cataratta canina è una patologia oculare caratterizzata dall’opacizzazione parziale o completa del cristallino, la lente biconvessa trasparente situata dietro l’iride che focalizza la luce sulla retina. Questa condizione rappresenta una delle principali cause di cecità nel cane, con un’incidenza stimata del 5-10% nella popolazione canina generale, raggiungendo percentuali significativamente superiori in alcune razze predisposte. La cataratta può manifestarsi in qualsiasi età, dalla forma congenita presente alla nascita fino alle varianti senili che si sviluppano nell’età avanzata.
Il meccanismo fisiopatologico della cataratta coinvolge l’alterazione della struttura normale delle fibre cristalline, proteine specializzate che conferiscono trasparenza al cristallino. Quando queste proteine si denaturano, si aggregano o subiscono modificazioni chimiche, perdono la loro organizzazione ordinata causando dispersione della luce e conseguente opacizzazione. Questo processo può essere reversibile nelle fasi iniziali ma diventa irreversibile con la progressione, rendendo fondamentale la diagnosi precoce per ottimizzare le possibilità terapeutiche.
La classificazione della cataratta si basa su diversi parametri: età di insorgenza (congenita, giovanile, adulta, senile), localizzazione anatomica (nucleare, corticale, capsulare), grado di opacizzazione (incipiente, immatura, matura, ipermatura) e eziologia (ereditaria, diabetica, traumatica, tossica). Ogni tipologia presenta caratteristiche prognostiche specifiche che influenzano l’approccio terapeutico e le aspettative di successo chirurgico. La forma più comune nel cane è la cataratta ereditaria, che può manifestarsi in età giovanile o adulta secondo specifici pattern genetici razza-specifici.
Cane con cataratta: esempi



Anatomia e funzione del cristallino
Il cristallino canino è una struttura biconvessa avascolare e trasparente del diametro di circa 8-12 millimetri, sospesa dietro l’iride tramite fibre zonulari che si inseriscono sul muscolo ciliare. Questa lente biologica è costituita da tre componenti principali: la capsula cristallinoidea (membrana basale elastica che avvolge completamente il cristallino), la corteccia (strato esterno di fibre cristalline giovani) e il nucleo (porzione centrale formata dalle fibre cristalline più antiche depositate durante lo sviluppo embrionale).
Le fibre cristalline sono cellule specializzate allungate che hanno perso gli organelli cellulari durante la differenziazione per massimizzare la trasparenza. Queste cellule contengono elevate concentrazioni di proteine specifiche chiamate cristalline (alfa, beta e gamma), organizzate in una struttura ordinata che permette il passaggio della luce senza dispersione. La mancanza di vascolarizzazione rende il cristallino dipendente dall’umor acqueo per il metabolismo e la rimozione dei prodotti di scarto, attraverso un sistema di trasporto attivo che mantiene l’equilibrio idro-elettrolitico.
La funzione principale del cristallino è la messa a fuoco delle immagini sulla retina attraverso la modificazione della sua curvatura (accomodazione). Nel cane, l’accomodazione è limitata rispetto all’uomo, ma il cristallino mantiene un ruolo cruciale nel sistema ottico complessivo. La trasparenza cristallinoidea dipende da fattori multipli: organizzazione ordinata delle fibre, assenza di organelli che potrebbero disperdere la luce, controllo preciso del contenuto idrico e mantenimento dell’integrità delle proteine cristalline. Qualsiasi alterazione di questi fattori può determinare l’opacizzazione caratteristica della cataratta.
Cause della cataratta nel cane
L’eziologia della cataratta canina è multifatoriale e comprende componenti genetiche, metaboliche, traumatiche e degenerative che possono agire singolarmente o in combinazione. La predisposizione genetica rappresenta la causa più comune, con oltre 100 razze canine che presentano forme ereditarie di cataratta trasmesse secondo diversi pattern mendeliani. Le mutazioni genetiche identificate coinvolgono geni responsabili dello sviluppo cristallinoideo, del metabolismo delle proteine cristalline e del mantenimento della trasparenza, causando cataratte che si manifestano in età e modalità caratteristiche per ciascuna razza.
Il diabete mellito costituisce una causa significativa di cataratta acquisita, con oltre l’80% dei cani diabetici che sviluppa cataratta entro 12 mesi dalla diagnosi. Il meccanismo patogenetico coinvolge l’accumulo di sorbitolo nel cristallino attraverso la via metabolica del poliolio: l’iperglicemia cronica porta alla conversione del glucosio in sorbitolo tramite l’enzima aldoso reduttasi, causando rigonfiamento osmotico delle fibre cristalline e successiva denaturazione proteica. Questa forma di cataratta può svilupparsi rapidamente (settimane o mesi) e spesso progredisce verso la cecità completa.
Traumi oculari possono causare cataratta attraverso danno diretto al cristallino o alterazione dei meccanismi nutritivi. Contusioni, perforazioni, corpi estranei intraoculari e lesioni da radiazioni possono determinare opacizzazione immediata o ritardata. Infiammazioni intraoculari croniche (uveiti) possono causare cataratta secondaria attraverso la liberazione di mediatori infiammatori che alterano il metabolismo cristallinoideo. Fattori nutrizionali come carenze di aminoacidi essenziali, vitamine o antiossidanti possono contribuire allo sviluppo di cataratta, particolarmente in cuccioli in crescita. Farmaci come corticosteroidi sistemici prolungati possono indurre cataratta iatrogena, mentre l’invecchiamento causa cataratta senile attraverso l’accumulo di danni ossidativi e modificazioni proteiche legate all’età.
Tipi di cataratta canina
La cataratta congenita è presente alla nascita e deriva da anomalie dello sviluppo embrionale del cristallino. Questa forma può essere associata a microftalmo, persistenza della membrana pupillare o altre malformazioni oculari congenite. La cataratta congenita può essere completa (interessando tutto il cristallino) o parziale (limitata a specifiche regioni), influenzando significativamente lo sviluppo della visione normale. I cuccioli affetti possono mostrare compromissione visiva evidente fin dalle prime settimane di vita, richiedendo intervento chirurgico precoce per prevenire deprivazione visiva e ambliopia.
La cataratta giovanile si manifesta tipicamente entro i primi 6 anni di vita e rappresenta la forma più comune nelle razze predisposte. Questa variante può progredire rapidamente verso la maturità completa o rimanere stabile per anni, a seconda del genotipo specifico e dei fattori ambientali. La cataratta ereditaria mostra pattern di trasmissione caratteristici: autosomica recessiva (Labrador Retriever, Golden Retriever), autosomica dominante (Boston Terrier, Staffordshire Bull Terrier) o legata al sesso (raramente descritta nel cane).
La cataratta senile si sviluppa in cani anziani (>8 anni) come conseguenza dell’invecchiamento naturale del cristallino. Questa forma progredisce generalmente lentamente e può rimanere incompleta per anni, causando riduzione graduale della vista piuttosto che cecità acuta. La cataratta diabetica rappresenta una forma acquisita caratterizzata da progressione rapida (settimane-mesi) e tendenza alla maturazione completa bilaterale. Questa variante può essere associata a cataratta ipermatura con rigonfiamento del cristallino e possibili complicanze come uveite facolitica o glaucoma secondario.
Cataratte traumatiche risultano da lesioni oculari dirette e possono presentare morfologia irregolare con aree di opacizzazione localizzate. Cataratte secondarie si sviluppano come conseguenza di altre patologie oculari (uveiti croniche, glaucoma, atrofia progressiva della retina) e spesso presentano prognosi più riservata per le alterazioni associate di altre strutture oculari.
Sintomi della cataratta nel cane
I sintomi della cataratta canina variano significativamente in base al grado di opacizzazione, alla velocità di progressione e alla localizzazione anatomica delle opacità cristallinoidee. Il segno più evidente è l’opacizzazione visibile del cristallino, che appare come un’area biancastra, grigiastra o bluastra nella pupilla, particolarmente evidente con illuminazione diretta. Nelle fasi iniziali, l’opacità può essere appena percettibile o visibile solo con specifiche angolazioni luminose, mentre nelle cataratte mature l’intero cristallino appare opaco e la pupilla assume un aspetto “lattescente”.
I deficit visivi si manifestano inizialmente in condizioni di scarsa illuminazione, poiché le cataratte riducono la quantità di luce che raggiunge la retina. I cani possono mostrare esitazione durante le passeggiate serali, difficoltà a localizzare oggetti in penombra, riluttanza a scendere scale buie o comportamenti di ricerca tattile aumentata. Con la progressione, i deficit si estendono alle condizioni di luce normale, causando difficoltà nella navigazione ambientale, collisioni con oggetti, perdita di coordinazione durante il gioco e ridotta responsività agli stimoli visivi.
Cambiamenti comportamentali caratteristici includono maggiore dipendenza dalle vocalizzazioni del proprietario, riluttanza a esplorare ambienti nuovi, preferenza per percorsi familiari e aumentata ricerca di contatto fisico. Alcuni cani sviluppano ansia correlata alla perdita visiva, manifestando agitazione in situazioni non familiari o attaccamento eccessivo al proprietario. Segni compensatori includono aumento dell’uso dell’olfatto e dell’udito, sviluppo di mappe mentali degli ambienti familiari e adattamenti posturali per ottimizzare la percezione spaziale.
In casi di cataratta rapidamente progressiva (tipicamente diabetica), i cani possono mostrare disorientamento acuto, perdita improvvisa della capacità di localizzare cibo e acqua, e stress comportamentale significativo per l’adattamento rapido richiesto, oltre che problemi oculari generali. Complicanze associate possono includere uveite secondaria con arrossamento oculare, dolore e lacrimazione, o glaucoma secondario con aumento della pressione intraoculare che causa dolore e ulteriore compromissione visiva.
Progressione della cataratta canina
La progressione della cataratta segue pattern caratteristici che variano in base all’eziologia e ai fattori individuali del paziente. Nelle cataratte ereditarie, la progressione può essere lenta e prevedibile, sviluppandosi nell’arco di mesi o anni con fasi distinte: incipiente (opacità minima <10% del cristallino), immatura (opacità parziale 10-99%), matura (opacità completa 100%) e ipermatura (riassorbimento delle proteine cristalline con possibile riduzione dell’opacità ma perdita della struttura normale).
Le cataratte diabetiche mostrano tipicamente progressione accelerata con passaggio dalla normalità alla maturità completa in settimane o pochi mesi. Questa rapida evoluzione è correlata all’accumulo veloce di sorbitolo e al conseguente rigonfiamento osmotico delle fibre cristalline. La progressione bilaterale simmetrica è caratteristica, anche se un occhio può essere leggermente in anticipo rispetto al controlaterale. Segni precoci specifici includono rigonfiamento del cristallino con ipermetropia transitoria e possibile instabilità del cristallino per alterazione delle fibre zonulari.
Fattori che influenzano la progressione includono controllo glicemico nel diabete, presenza di infiammazioni oculari concomitanti, traumi oculari minori, stress ossidativo sistemico e fattori genetici modificanti. Cataratte senili progrediscono generalmente lentamente e possono rimanere incomplete per anni, causando compromissione visiva graduale che permette migliore adattamento comportamentale. Alcune cataratte senili si stabilizzano senza raggiungere la maturità completa.
Complicanze della progressione includono uveite facolitica (infiammazione causata dalla fuoriuscita di proteine cristalline), glaucoma facolítico (aumento della pressione intraoculare secondario all’infiammazione), lussazione del cristallino (rottura delle fibre zonulari) e atrofia retinica secondaria per deprivazione luminosa prolungata. Monitoraggio della progressione richiede valutazioni oftalmologiche regolari per determinare il timing ottimale dell’intervento chirurgico e prevenire complicanze irreversibili.
Diagnosi, esami e prognosi della cataratta
La diagnosi di cataratta richiede un esame oftalmologico completo e specialistico che combina valutazione clinica, test funzionali e imaging diagnostico avanzato. L’anamnesi dettagliata deve includere età di insorgenza dei sintomi, velocità di progressione, storia familiare di cataratta, presenza di diabete mellito, traumi oculari precedenti e farmaci utilizzati. L’esame inizia con la valutazione della vista in condizioni di luce variabile, test di navigazione in ambienti controllati e valutazione delle risposte pupillari per escludere patologie retiniche o neurologiche concomitanti.
L’esame con lampada a fessura (biomicroscopia) rappresenta l’esame gold standard per la diagnosi definitiva, permettendo la visualizzazione dettagliata del cristallino con ingrandimento elevato e illuminazione controllata. Questa tecnica permette di determinare la localizzazione precisa delle opacità (nucleare, corticale, subcapsulare), il grado di maturazione, la presenza di rigonfiamento cristallinoideo e l’integrità della capsula. La oftalmoscopia valuta la trasparenza dei mezzi ottici e permette l’esame del fondo oculare per escludere patologie retiniche concomitanti.
Test diagnostici specialistici includono l’elettroretinografia (ERG) per valutare la funzionalità retinica in presenza di cataratte dense che impediscono l’esame del fondo oculare. Questo test è essenziale prima dell’intervento chirurgico per confermare l’integrità retinica e predire il successo visivo post-operatorio. L’ecografia oculare può essere necessaria in cataratte ipermature per valutare l’anatomia delle strutture posteriori e identificare eventuali complicanze come distacco di retina o alterazioni vitreali.
Esami ematobiochimici sono indicati per identificare patologie sistemiche sottostanti, particolarmente diabete mellito che richiede stabilizzazione metabolica prima dell’intervento chirurgico. La tonometria misura la pressione intraoculare per escludere glaucoma secondario. La prognosi della cataratta è generalmente eccellente con trattamento chirurgico appropriato: il 90-95% dei cani recupera visione funzionale con facoemulsificazione e impianto di lenti intraoculari, mentre la prognosi è riservata senza trattamento per la progressione verso cecità completa.
Razze di cane predisposte
La predisposizione razziale alla cataratta nel cane è ben documentata e riflette fattori genetici ereditari che predispongono allo sviluppo di opacità cristallinoidee in età e modalità caratteristiche. Il Cocker Spaniel Americano presenta una delle incidenze più elevate, con cataratta ereditaria che si manifesta tipicamente in età giovanile (1-4 anni) e progredisce rapidamente verso la maturità completa. Il pattern di trasmissione è autosomica recessiva, con penetranza variabile che può causare espressione eterogenea anche all’interno della stessa famiglia.
Il Golden Retriever e il Labrador Retriever mostrano predisposizione per cataratta ereditaria a trasmissione autosomica recessiva che tipicamente si manifesta dopo i 6 anni di età. Queste razze presentano spesso cataratta nucleare posteriore che può rimanere incompleta per anni prima di progredire. Il Pastore Tedesco sviluppa frequentemente cataratta giovanile con pattern di trasmissione complesso che può coinvolgere geni multipli. Il Boston Terrier presenta cataratta ereditaria autosomica dominante con manifestazione precoce e progressione variabile.
Razze toy come Barboncino Toy, Yorkshire Terrier e Maltese mostrano predisposizione per cataratta congenita o giovanile precoce, spesso associata ad altre anomalie oculari congenite. Il Siberian Husky e l’Alaskan Malamute presentano forme specifiche di cataratta posteriore polare che possono rimanere stabili o progredire lentamente. Il Rottweiler e il Dobermann sviluppano tipicamente cataratta senile con insorgenza dopo gli 8 anni.
Diabete e cataratta mostrano correlazioni razziali specifiche: razze predisposte al diabete mellito come Samoyedo, Keeshond e Pinscher Nano presentano rischio elevato di cataratta diabetica secondaria. Test genetici sono disponibili per alcune razze e permettono l’identificazione di portatori per programmi di allevamento responsabile. La prevenzione attraverso screening genetico e selezione riproduttiva ha significativamente ridotto l’incidenza in alcune popolazioni, mentre l’identificazione precoce in razze predisposte permette monitoraggio oftalmologico proattivo e intervento tempestivo.
Cura, trattamento e prevenzione della cataratta
Il trattamento definitivo della cataratta è esclusivamente chirurgico, non esistendo farmaci o terapie conservative efficaci per invertire l’opacizzazione cristallinoidea. La facoemulsificazione rappresenta la tecnica chirurgica gold standard, utilizzando ultrasuoni ad alta frequenza per frammentare il cristallino opaco e aspirare i frammenti attraverso incisioni corneali minimali. Questa procedura viene tipicamente combinata con l’impianto di lenti intraoculari artificiali per ripristinare la capacità di messa a fuoco e ottimizzare la qualità visiva post-operatoria.
La selezione dei candidati chirurgici richiede valutazione multifatoriale che include grado di cataratta, funzionalità retinica confermata dall’elettroretinografia, assenza di patologie oculari concomitanti gravi, controllo di condizioni sistemiche come diabete mellito e condizioni generali compatibili con anestesia generale. Timing chirurgico ottimale è cruciale: l’intervento dovrebbe essere eseguito quando la cataratta causa compromissione visiva significativa ma prima dello sviluppo di complicanze come uveite facolitica o glaucoma secondario.
Preparazione pre-operatoria include stabilizzazione metabolica in cani diabetici, controllo dell’infiammazione oculare con terapie topiche, antibiotici profilattici e dilatazione pupillare. La chirurgia richiede anestesia generale e dura tipicamente 45-90 minuti per occhio. Complicanze chirurgiche possibili includono rottura capsulare posteriore, perdita vitreale, emorragia intraoculare e aumento transitorio della pressione intraoculare, gestibili con tecniche microchirurgiche specialistiche.
Il post-operatorio richiede terapie topiche intensive con antibiotici e antinfiammatori per 4-6 settimane, restrizioni dell’attività fisica, protezione oculare con collare elisabettiano e controlli oftalmologici ravvicinati. Successo chirurgico si raggiunge nel 90-95% dei casi con recupero di visione funzionale entro 2-4 settimane. Complicanze post-operatorie includono uveite, glaucoma secondario, opacizzazione capsulare e distacco di retina, gestibili con terapie mediche specifiche o interventi chirurgici aggiuntivi quando necessario.
Alimentazione per il cane con cataratta
La gestione nutrizionale del cane con cataratta si concentra sul supporto della salute oculare generale e, nei casi di cataratta diabetica, sul controllo rigoroso della glicemia attraverso diete specifiche. Antiossidanti svolgono un ruolo protettivo importante nella prevenzione della progressione della cataratta e nel supporto della guarigione post-chirurgica. Vitamina E (5-10 UI/kg), vitamina C (25-50 mg/kg) e selenio (0,1-0,3 mg/kg) proteggono il cristallino dal danno ossidativo e supportano l’integrità delle membrane cellulari oculari.
Carotenoidi come luteina e zeaxantina si concentrano nei tessuti oculari e forniscono protezione contro la luce blu e i radicali liberi. Questi composti sono naturalmente presenti in verdure a foglia verde, mais e carote, ma possono essere integrati in dosaggi terapeutici (5-20 mg/die) sotto supervisione veterinaria. Acidi grassi omega-3 (EPA e DHA) supportano la salute delle membrane cellulari retiniche e possono avere effetti anti-infiammatori che beneficiano l’ambiente oculare.
Per cani diabetici con cataratta, la gestione dietetica è cruciale per il controllo glicemico ottimale. Diete ad alto contenuto di fibre (15-25%) rallentano l’assorbimento dei carboidrati e stabilizzano la glicemia post-prandiale. Carboidrati complessi a basso indice glicemico sono preferibili, mentre zuccheri semplici devono essere rigorosamente evitati. Proteine di alta qualità (25-30% della sostanza secca) supportano il mantenimento della massa muscolare e forniscono sazietà duratura.
Pasti regolari sincronizzati con la somministrazione di insulina sono essenziali per evitare fluttuazioni glicemiche che possono accelerare la progressione della cataratta. Integrazione specifica può includere zinco (1-2 mg/kg) per la salute retinica, vitamina A (in dosaggi appropriati per evitare tossicità) per la funzione visiva e coenzima Q10 per il supporto energetico cellulare. Durante il periodo post-operatorio, diete facilmente digeribili riducono lo stress sistemico e supportano la guarigione, mentre l’idratazione adeguata è importante per mantenere la pressione intraoculare ottimale.
Consigli del veterinario per la cataratta del cane
La gestione domiciliare del cane con cataratta richiede adattamenti ambientali e comportamentali per compensare la compromissione visiva e garantire sicurezza e qualità di vita. Modifiche ambientali fondamentali includono mantenimento di percorsi liberi da ostacoli, evitare spostamenti di mobili, illuminazione adeguata e costante degli ambienti frequentati, e creazione di landmark tattili e olfattivi per facilitare la navigazione. Pavimenti antiscivolo e protezioni per spigoli vivi riducono il rischio di traumi durante la deambulazione.
Routine stabili sono cruciali per i cani con deficit visivi: mantenere orari fissi per pasti, passeggiate e attività, utilizzare sempre gli stessi percorsi per le uscite, e posizionare cibo e acqua nelle stesse location. Comunicazione vocale aumentata aiuta il cane a localizzare il proprietario e a navigare l’ambiente: utilizzare comandi verbali specifici per direzioni, avvertimenti e incoraggiamenti. Giocattoli sonori o profumati possono sostituire quelli visivi per mantenere stimolazione mentale e fisica appropriata.
Monitoraggio clinico deve includere osservazione quotidiana per segni di dolore oculare (arrossamento, lacrimazione, chiusura palpebrale), progressione della cataratta e sviluppo di complicanze. Segni di emergenza che richiedono valutazione veterinaria immediata includono dolore oculare acuto, pupille dilatate fisse, arrossamento severo e perdita improvvisa della visione residua. Controlli oftalmologici regolari ogni 3-6 mesi permettono monitoraggio della progressione e identificazione precoce di complicanze.
Per cani candidati chirurgici, è importante mantenere salute oculare ottimale evitando traumi, controllando condizioni sistemiche come diabete e seguendo scrupolosamente le terapie prescritte. Preparazione psicologica del proprietario è importante: comprendere procedure chirurgiche, aspettative realistiche, impegno post-operatorio e costi associati. Educazione sui segni di complicanze post-chirurgiche e l’importanza dell’aderenza alle terapie topiche intensive è cruciale per il successo dell’intervento. Supporto emotivo durante l’adattamento alla compromissione visiva aiuta sia il cane che la famiglia a mantenere qualità di vita ottimale durante tutto il percorso terapeutico.
Aspettative di vita con cataratta
Le aspettative di vita per cani con cataratta non sono generalmente influenzate dalla presenza della cataratta stessa, ma piuttosto dalle condizioni sistemiche sottostanti che possono averla causata. La cataratta è una condizione locale che non comporta rischi vitali diretti, permettendo una longevità normale con appropriate misure di supporto e adattamenti ambientali. Tuttavia, fattori prognostici specifici influenzano significativamente la qualità di vita e le aspettative funzionali del paziente.
Cani diabetici con cataratta possono avere aspettative di vita ridotte se il diabete non è adeguatamente controllato, indipendentemente dalla presenza della cataratta. Il controllo glicemico ottimale è essenziale non solo per prevenire la progressione della cataratta ma anche per evitare complicanze sistemiche del diabete come chetoacidosi, neuropatie e nefropatie. Cataratte ereditarie in cani altrimenti sani non influenzano la longevità, e molti cani vivono vite normali e soddisfacenti anche con cecità completa grazie alla loro capacità di adattamento.
Qualità di vita può rimanere eccellente anche senza intervento chirurgico, purché vengano implementati appropriati adattamenti ambientali e comportamentali. Cani con cataratta non trattata sviluppano tipicamente strategie compensatorie efficaci utilizzando olfatto, udito e memoria spaziale per navigare ambienti familiari. Tuttavia, complicanze secondarie come uveite cronica o glaucoma possono causare dolore significativo e richiedere gestione medica continua o, nei casi severi, enucleazione dell’occhio.
Intervento chirurgico tempestivo offre le migliori prospettive per mantenimento della funzione visiva e prevenzione di complicanze. Successo chirurgico a lungo termine è eccellente, con oltre il 90% dei pazienti che mantiene visione funzionale per anni dopo la facoemulsificazione. Fattori che influenzano la prognosi a lungo termine includono l’età al momento dell’intervento, la presenza di comorbidità oculari, l’aderenza alle terapie post-operatorie e la prevenzione di traumi oculari successivi.
Controlli oftalmologici annuali permettono identificazione precoce di complicanze tardive come opacizzazione capsulare posteriore, gestibile con procedure laser minimamente invasive.
LIBRETTO VETERINARIO
Con il libretto veterinario di DoctorVet è possibile registrare e aggiornare informazioni importanti sulla salute del proprio animale, soprattutto se è soggetto a patologie o malato.
Il libretto sanitario ti aiuta a gestire vaccinazioni e trattamenti periodici. Puoi caricare prescrizioni, diagnosi, farmaci, esami, referti e note cliniche.
Attiva i promemoria per una gestione più facile ed efficace.
*Il veterinario può aggiornare il libretto veterinario con nuove informazioni, prescrizioni, terapie, analisi, esami e referti, consentendo una migliore gestione della salute dell’animale.